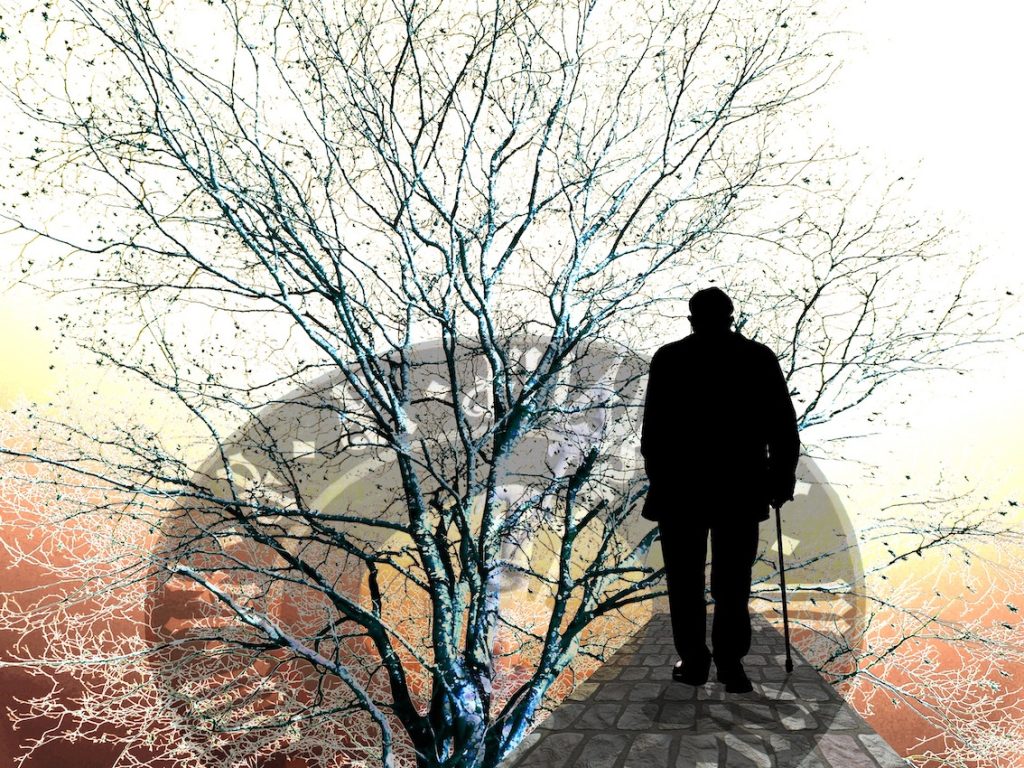Nel suo romanzo Bruno Arpaia costruisce una tramatura complessa per parlarci di Alzheimer e decadenza fisica
Ha molti solchi narrativi l’ultimo libro di Bruno Arpaia, Ma tu chi sei, scrittore raffinato e civile di molti romanzi, ma anche impeccabile traduttore che ha dato voce a grandi autori della letteratura spagnola e latino-americana, tra i quali García Márquez, Cortázar e Cercas. Il primo è una sorta di motore, motivo e fil rouge, i suoi incontri con la vecchia madre malata di Alzheimer che vede periodicamente in una casa di Ottaviano, successivamente in una casa di riposo per lungodegenti, segnati da dialoghi serrati e incalzanti da teatro dell’assurdo, di una comicità esilarante e allo stesso tempo dolorosa, ma che gli serve da baricentro per allargare ad altre porzioni di senso.
A volte durante questi incontri non lo riconosce, non ricorda il nome di sua moglie. L’ossessione per la malattia, il decadimento e la perdita di memoria della madre resta in tutto il libro il nervo angosciato e scoperto da cui s’innervano tutti gli altri ragionamenti e congetture di «uno smisurato senso di perdita e di lutto», perché «senza futuro, il presente è solo disordine e dolore», come la perdita di passato «è una forma di morte sempre presente all’interno della vita». La perdita è quindi un pezzo di vita privata ma anche un pezzo di mondo che se va, «in qualche modo io sono anche i ricordi che lei ha di me», scrive di un patrimonio che svanisce, ed è una cosa che riguarda tutti. Perché questo non è solo un memoir, non è solo una storia intima, come ci avverte facendo intendere le sue intenzioni: «non è un’autobiografia, e la scrittura non è un confessionale», afferma in polemica con la cosiddetta autofiction che quando non diventa letteratura (Carrère, Ernaux, il Manuel Vilas di In tutto c’è stata bellezza, sempre tradotto da Arpaia) si riduce a confessione narcisistica, memoriale solipsistico, a scrittura dell’io.
Un’altra traccia di questo ibrido è una riflessione sulla morte e la decadenza fisica a partire da sé nella stagione di precarietà esistenziale segnata dalla pandemia, perché «Andare avanti negli anni significa confrontarsi di continuo con il proprio corpo», scrive l’autore, ma anche con la solitudine del fine vita che ci riserva l’epoca che affida alle parole dello scrittore argentino Mempo Giardinelli in quella che è una spietata riflessione sul tema del declino: «tutti soli, nella penombra di una miserabile saletta di terapia intensiva, con le sonde infilate anche nel culo e la dignità completamente perduta». Questi diversi solchi si alternano, si intrecciano, riverberano in una tramatura complessa che parte dalla vita vera per diventare narrazione e indagine scientifica, storica, in un libro capace di mescolare eccentricamente elementi saggistici, filosofici, pagine di reportage esistenziale.
Oltre ai fatti, alla vita che scorre in presa diretta, guardata con senso critico da osservatore militante, l’autore riflette anche sulla figura del fisico Heisenberg, «l’uomo che aveva scoperto il principio di indeterminazione, che aveva svelato al mondo l’ambiguità e l’inafferrabilità della realtà», o indaga la vicenda di Rebecca Sharrock, malata di ipertimesia e capace di una memoria autobiografica prodigiosa, fagocitata da flussi di ricordi incontrollabili. In questo modo Arpaia – riuscendo a innovare la forma romanzo in modo contemporaneo – crea coraggiosamente una narrazione complessa e problematica che diventa un sedimentato complesso di sensi diversi. Così facendo rimette anche in circolo molta letteratura, da Kundera a Mario Vargas Llosa, passando per Cechov, Borges, Semprùn, e naturalmente per la vicenda collettiva e generazionale degli anni ’70, persino per la memoria dispersa dei suoi libri, in modo tale che la propria storia ci riguarda perché diventa la storia di tutti.
Ma questo è anche un libro pensato volutamente senza finzione, nel tentativo di rovesciare l’idea del romanzesco: «non potevo e non dovevo manipolare e mascherare la mia esperienza personale con le tecniche del romanziere per parlare di quello che mi stava a cuore, non dovevo affidarmi all’abilità narrativa o alla plasticità di un romanzo per centrare il bersaglio». Arpaia allora scrive «senza rete», sempre in bilico, senza inseguire il pathos, cercando (e trovando) la naturalezza della lingua umana della vita per la sua ispirata confessione, con l’angoscia di possedere solo un infinitesimo della sua biografia, che gli sfugge, perché come ha già scritto in un suo altro libro indimenticabile, Il passato davanti a noi, «la memoria inventa», affabula, racconta, e «per esistere, dobbiamo raccontarci anche a noi stessi, e quel racconto, anche se non vogliamo, è pieno di bugie».
La memoria è come un romanzo a lieto fine: «fa tutto il necessario perché il racconto funzioni (…) e ci renda piacevoli a noi stessi.» E come ha scritto Jonathan Gottschall, ogni autobiografia pubblicata dovrebbe avere questa dicitura: «Questa storia che racconto su me stesso è soltanto tratta da una storia vera. Sono in larga parte io stesso un frutto ardente della mia immaginazione».