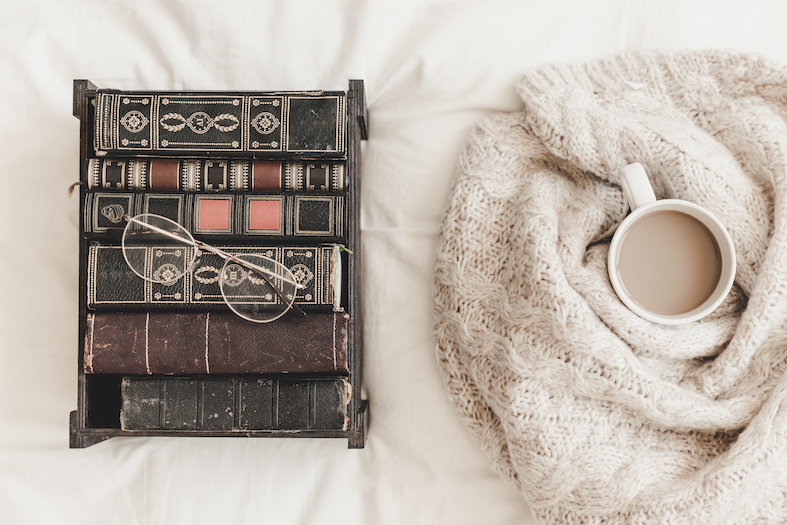Tra il ludico e il dilettevole - La lettura è uno specchio della nostra società, dei suoi cliché, delle sue derive e delle sue paure
Ricordo in modo distinto una pubblicità di una marca di caffè solubile su una rivista inglese. C’era un tizio, vestito in maniera formale, seduto su una poltrona in una stanza oltremodo spoglia, se non per alcuni oggetti: una tazza di caffè appoggiata su un tavolino, e un libro in edizione hardcover che l’uomo tiene in mano. L’intento è di rappresentare un uomo placidamente assorto nella lettura di un libro, un’espressione di soddisfazione in volto che si riverbera sul prodotto reclamizzato.
A dirla tutta, quell’immagine mi risultò subito ingannevole, forzata. Avete presente quando nei cataloghi di vestiti dei grandi magazzini trovate dei ragazzoni che, indossando delle pesanti giacche imbottite, giocano entusiasti una partita di beach volley sotto il sole cocente? Non so se avete mai giocato a beach volley, ma farlo indossando una giacca imbottita sotto la stecca del sole, equivale più o meno a giocare un torneo di street basket con gli scarponi da sci.
Nel caso della pubblicità del caffè la forzatura, certo, non era così palese, ma c’erano dei dettagli che rendevano l’immagine poco plausibile. I lettori navigati sanno, per esempio, che non è particolarmente piacevole leggere un’edizione hardcover di un libro e che, potendo scegliere, è molto più maneggevole quella economica. Per cui, se un pubblicitario volesse veramente comunicare in un’immagine il piacere della lettura, farebbe meglio a scegliere un’edizione economica, non una hardcover. Queste sono utili, semmai, a chi pensa che il libro sia una sorta di soprammobile che conferisce un’aura di rispettabilità ma che, temo, si guarderebbe bene dal passare ore di piacevole ozio immerso nella lettura.
C’è chi pensa che i libri servano a essere letti, e c’è chi, pur non coltivando il passatempo della lettura, non rinuncia al prestigio vicario che la presenza di titoli importanti sembra misteriosamente diffondere nell’aria.
Nel 2006, la giornalista del «New York Times» Alex Kuczynski pubblica Beauty Junkies (La bella e la bestia, Elliot, 2008) un libro sul mondo della chirurgia estetica. Durante la ricerca e la raccolta di dati che porta alla pubblicazione, Kuczynski intervista i professionisti del settore e, improvvisandosi antropologa, sperimenta sulla propria pelle – nel vero senso della parola, è il caso di dirlo – alcune delle procedure particolarmente in voga in quel momento. A un certo punto della sua inchiesta ottiene un appuntamento con un importante chirurgo plastico, che la invita nel suo ufficio. Qui, Kuczynski non può fare a meno di notare che «diversi scaffali sono riempiti di libri finti, i cui dorsi dovrebbero assomigliare a quelli di prime edizioni rilegate in pelle». Sulla scrivania del chirurgo plastico – prosegue la giornalista – «c’è un porta fazzoletti quadrato, con lo stesso tema: i fazzoletti sembrano essere tenuti assieme da vecchie edizioni de Il grande Gatsby, La lettera scarlatta e Vanity Fair. A differenza delle false copertine dei libri, che creano una sorta di villaggio Potëmkin del successo letterario, il porta fazzoletti non ha senso nella sua ovvia falsità. Quale rilegatore del XIX secolo avrebbe strappato i dorsi delle sue prime edizioni per farne un porta fazzoletti?».
I falsi libri – che in inglese si chiamano faux-books –, l’avrete capito, sono degli involucri vuoti che riproducono la copertina di classici della letteratura e che vengono usati come soprammobili. I lettori avveduti, lo sappiamo, non sono insensibili all’estetica dell’oggetto libro, e sanno apprezzare il design di una bella copertina. Dei libri, come abbiamo visto, amano anche la consistenza, lo spessore, l’odore delle pagine. Tenere in mano un libro può essere un’esperienza speciale, e finanche avere un che di sensuale ed erotico. Ma il piacere che il libro può dare rimane, sempre e comunque, essenzialmente quello della lettura, di quell’immersione nei mondi che la scrittura dischiude. E come si fa a leggere un libro vuoto? Quindi, di fronte a dei falsi libri, o faux-books, i lettori smaliziati non possono non riconoscere, e a ragione, un controsenso plateale, uno stratagemma di cattivo gusto, l’indizio imprescindibile di un harakiri intellettuale.
Il piacere e l’atto stesso della lettura sono complementari, e in un certo senso speculari, al piacere e all’atto della scrittura. Di recente si è parlato molto di intelligenza artificiale, ChatGPT, di macchine e di creatività. È chiaro che le macchine intelligenti sono in grado di scrivere un libro, o di realizzare un film. Al tempo stesso, però, continuo a nutrire forti dubbi sul senso ultimo di una simile operazione. Non mi lancerò in una riflessione sulla differenza fra l’intelligenza umana e l’intelligenza artificiale. Non questa volta: ma vi propongo un esperimento mentale. Avete presente il film Fahrenheit 451 di François Truffaut, tratto dal romanzo di Ray Bradbury? Provate a immaginare un remake, interamente realizzato dall’intelligenza artificiale, dove al posto dei classici, vengono bruciati libri scritti interamente da un’intelligenza artificiale. Non vi sembra che ci sarebbe qualcosa di strano, di vagamente assurdo? Non trovate che sarebbe come bruciare dei banali soprammobili, o, tanto per rimanere in tema, dei faux-books?