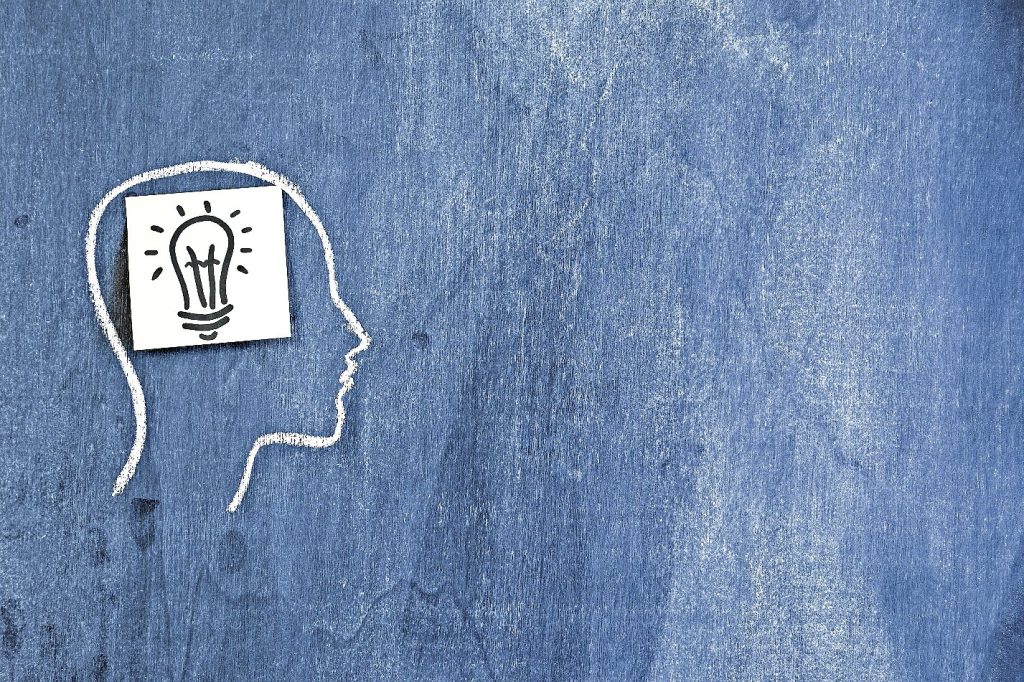L’avanzamento culturale di una società ha origine dalla qualità e quantità della sua produzione di conoscenzaA questo riguardo, il ruolo della tecnologia è oggi molto delicato e insieme ambiguo
In un’intervista televisiva di molti anni fa, il celebre pianista Maurizio Pollini, alla domanda sulla natura della musica, rispose, quasi irritato dal quesito insieme banale e infinitamente complesso: «La musica? La musica è conoscenza». Conoscere è un verbo che usiamo tutti i giorni ma, spesso, sbagliando poiché in realtà ci riferiamo alla semplice acquisizione di informazione. La conoscenza si nutre certamente di informazione ma non vi si riduce. È facile constatare che, per esempio, fare la conoscenza di una persona, di un nuovo testo letterario o di un paesaggio mai visto prima, implica sicuramente la raccolta di informazione, ma non come quando consultiamo l’orario ferroviario.
La conoscenza produce un insieme di relazioni mentali e significati, razionali ed emotivi, che vanno decisamente al di là dei «dati» portati all’attenzione del cervello dai nostri sensi. La definizione del Maestro Pollini, in questo quadro, è quanto mai preziosa. Il testo musicale e la sua esecuzione sono proposti come un «paesaggio» sempre nuovo che si presenta come un evento intellettuale al pari di una nuova teoria scientifica, di una scoperta o di una nuova tecnologia e ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di un evento accertato in ogni suo dettaglio. Inutile aggiungere, allora, che la filosofia, le arti e la stessa teologia sono primarie fonti di conoscenza poiché, nei casi migliori, propongono una visione, del mondo fisico o di quello metafisico, che induce nuovi stati mentali e nuovi spunti di riflessione. Se ci pensiamo, la nostra visione dell’esistenza, dell’andamento della storia e della società, è il frutto del nostro continuo coinvolgimento proprio in eventi conoscitivi.
Altra cosa è ciò che avviene quando riconosciamo qualcosa o qualcuno. Innanzitutto è chiaro che, per riconoscere qualcosa, dobbiamo averne fatto conoscenza in passato. Il riconoscimento può mobilitare stati d’animo precedenti, razionali ed emotivi, ma, in quanto tale, non genera alcunché di conoscitivamente nuovo. Di fatto, nella vita quotidiana così come in quella professionale, siamo molto più spesso attori di riconoscimento che di conoscenza. Inoltre, col passare degli anni, l’essere umano sostituisce gradualmente la conoscenza con il riconoscimento. Nella crescita tutto è conoscenza, anche se non elaborata, perché tutto appare naturalmente come nuovo mentre, a maturità avvenuta, riconoscere diviene l’attività prevalente e tutto tende a essere ricondotto a conoscenze, al plurale, ormai largamente consolidate che definiamo come il nostro «sapere». Si consideri la «divisione del lavoro» che riguarda le funzioni degli scienziati e dei medici. I primi studiano e diffondono le ultime conoscenze acquisite su una certa malattia e sui sintomi che essa presenta e il medico cercherà di riconoscere la loro presenza nei pazienti. Così, un esploratore raggiunge una meta, ancora non conosciuta, aprendo una via che, poi, dovrà riconoscere per tornare alla base di partenza. Il ruolo dell’informazione, per il riconoscimento, è sicuramente molto più strategico che non per la conoscenza. Mentre nel riconoscimento ciò che conta è l’accurata elaborazione dell’informazione disponibile, nei processi conoscitivi è indispensabile la valutazione critica e aperta della realtà.
È rilevante osservare che l’avanzamento culturale di una società ha origine dalla qualità e quantità della sua produzione di conoscenza perché, come appare evidente, se una comunità si limitasse a vedere le cose e ad agire contando unicamente sul riconoscimento, e, dunque, su ciò che già si conosce, non farebbe alcun passo avanti. Il ruolo della tecnologia è, a questo riguardo, molto delicato e insieme ambiguo. In effetti, per esempio nell’ambito dell’intelligenza artificiale, qualsiasi dispositivo, pur utilissimo, – sia esso hardware o software – si basa essenzialmente sulla abilità di riconoscere le situazioni più diverse – nella guida di un veicolo, delle funzioni organiche, delle strutture chimiche e così via – non essendo in grado né di scorgere problemi originali né, tanto meno, di proporre ipotesi o visioni creative che non siano riconducibili alle conoscenze e alle modalità logico-matematiche che l’uomo vi ha trasferito. Per ora, software e hardware possono stimolare l’attenzione dell’uomo e divenire possibili fonti di conoscenza solo quando, per qualche ragione, si comportano in modo imprevisto. Pur non rendendosene conto.