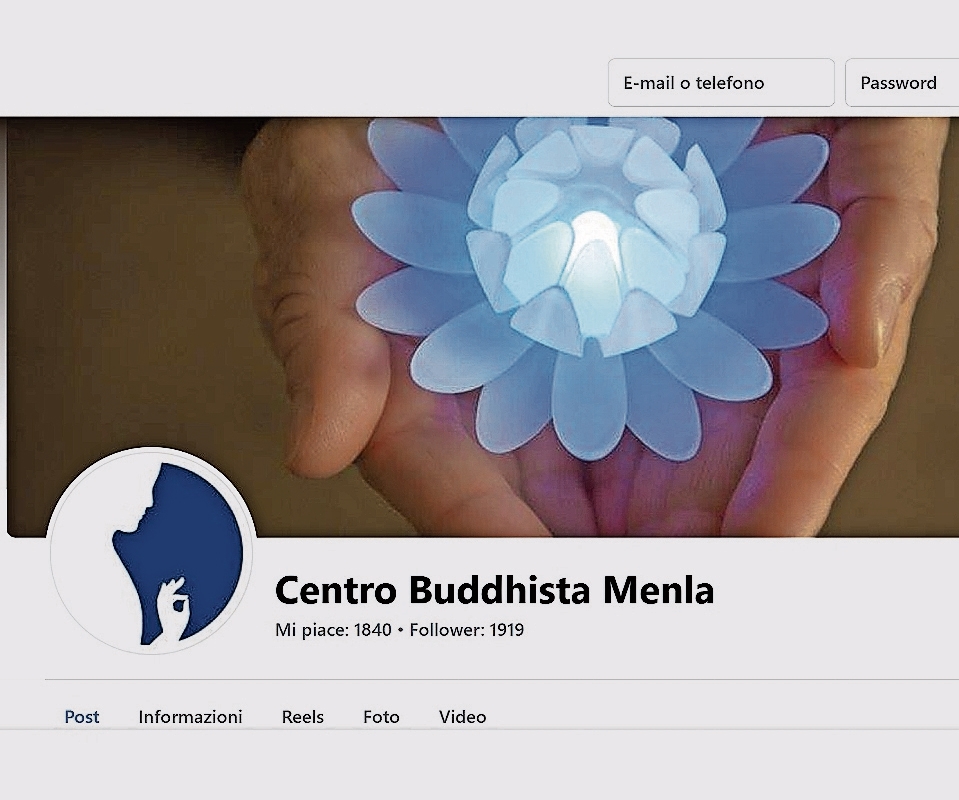Lo studio "L’infosfera religiosa del Canton Ticino" presenta una mappatura degli ambienti religiosi digitali
Può sembrare strano ma oggi anche l’esperienza religiosa, come ormai tutti gli aspetti della nostra vita, ha una dimensione digitale. E anche piuttosto attiva se guardiamo alle cifre che emergono dallo studio L’infosfera religiosa del Canton Ticino: una mappatura condotto dall’Istituto ReTe della Facoltà di Teologia di Lugano e cofinanziato dalla Rete integrata Svizzera per la sicurezza. La ricerca ha infatti identificato e catalogato 491 link: 348 appartenenti a pagine su piattaforme social come Facebook o Instagram e 143 appartenenti a siti web tradizionali. Questa mappatura dei luoghi religiosi digitali del Canton Ticino integra quella fisica prodotta dalla collaborazione tra il Servizio per l’integrazione degli stranieri del Canton Ticino (SIS) e il Centro intercantonale di informazione sulle credenze (CIC) di cui parla nel suo articolo Carlo Silini.
Ma come si è svolta la ricerca e quali sono i contenuti analizzati? Lo abbiamo chiesto al professor Adriano Fabris dell’Istutito ReTe: «Abbiamo analizzato e censito i luoghi digitali attivi in Ticino legati sia alle religioni tradizionali sia alle religioni più nuove, le new religions. Poi li abbiamo monitorati per sei mesi, sono stati raccolti 5211 contenuti. Il materiale trovato è davvero tanto, non credevamo che l’esperienza religiosa nel nostro cantone fosse così presente online. L’analisi si è poi svolta sulla base di 17 parametri che ci hanno fornito le indicazioni delle modalità e della qualità dell’interattività. Abbiamo così potuto offrire non solo una presentazione di tipo quantitativo dei risultati ma abbiamo anche potuto fare una riflessione su quelle che sono le trasformazioni dell’esperienza religiosa».
Il cofinanziamento da parte della Polizia federale, ci spiega il prof. Fabris, era finalizzato a un censimento dei siti religiosi digitali anche per capire se ci fossero dei segnali di radicalizzazione. A questo livello però i ricercatori non hanno rilevato nessun elemento riconducibile a estremismi, «anzi – puntualizza il prof. Fabris – quello che abbiamo visto in questo monitoraggio continuo di sei mesi è che la logica della polarizzazione tipica dei social non si è mai manifestata nella maniera in cui magari avviene su altri tipi di questioni di carattere culturale, sociale o politico».
Ma cos’altro è emerso dal monitoraggio? «Innanzitutto – racconta il prof. Fabris – una gerarchia nella presenza online, che vede ovviamente la presenza massiccia della Chiesa cattolica e delle chiese protestanti e avventiste, seguono le comunità musulmane e le comunità ortodosse, poi poche presenze di religioni orientali e una serie di realtà di new religions. Colpisce il fatto che in Ticino l’ebraismo non sia presente online, pur essendoci a Lugano una lunga tradizione di presenza ebraica. Al di là dell’elencazione quello che ci sembra importante è che i numeri sono un segno della vivacità religiosa e dell’adattabilità delle religioni alle nuove tecnologie. Abbiamo inoltre rilevato che questi diversi ambienti digitali sono relativi ciascuno al proprio ambito religioso, riguardano internamente le comunità e non c’è una interazione interreligiosa. Sono poche e poco attive le piattaforme di dialogo interreligioso che a mio avviso potrebbero forse venir maggiormente implementate. Un altro elemento che abbiamo colto è che l’attenzione a eventi di attualità o a questioni controverse non è molto presente, e che, questo stupisce, la lingua utilizzata è essenzialmente l’italiano. Infine, un elemento interessante è il fatto che i social più presenti sono quelli che diremmo “dei boomers”, come Facebook. Questo rivela che le comunità religiose si sono stabilizzate attorno a una certa età dei partecipanti e che c’è un problema di trasmissione alle giovani generazioni. L’utilizzo di Facebook e di Instagram incide anche sulle modalità di comunicazione, comporta cioè un largo uso delle immagini e questo anche per le tradizioni religiose che normalmente hanno cautele in questo senso, penso all’islam e a certe tradizioni ortodosse. È la prova che le tecnologie non sono dunque neutrali, condizionano e indirizzano le nostre forme di comunicazione».
L’utilizzo dei social da parte delle diverse comunità religiose oltre ad essere un atteggiamento figlio dei nostri tempi ha risvolti particolarmente importanti: «Crea comunità – osserva il prof. Fabris – è un modo per rafforzare la coesione tra le persone che si sviluppa non più solo con la partecipazione fisica ad attività o a riti. È nata insomma l’idea di una comunità virtuale che accompagna la presenza del fedele al di là del suo essere in un luogo fisico. Quello a cui assistiamo nelle comunità virtuali è una tendenza alla sostituzione delle relazioni con le connessioni. Non sappiamo se questa sostituzione avrà delle conseguenze e quali saranno, ma è interessante osservarla. Trovarsi in ambienti in cui il corpo e la carne non giocano un ruolo fondamentale è una novità, se pensiamo soprattutto alle tre religioni monoteistiche principali in cui l’uso del corpo è fondamentale all’interno del culto. Il rischio è che vi sia una sostituzione della realtà con la rappresentazione della realtà».