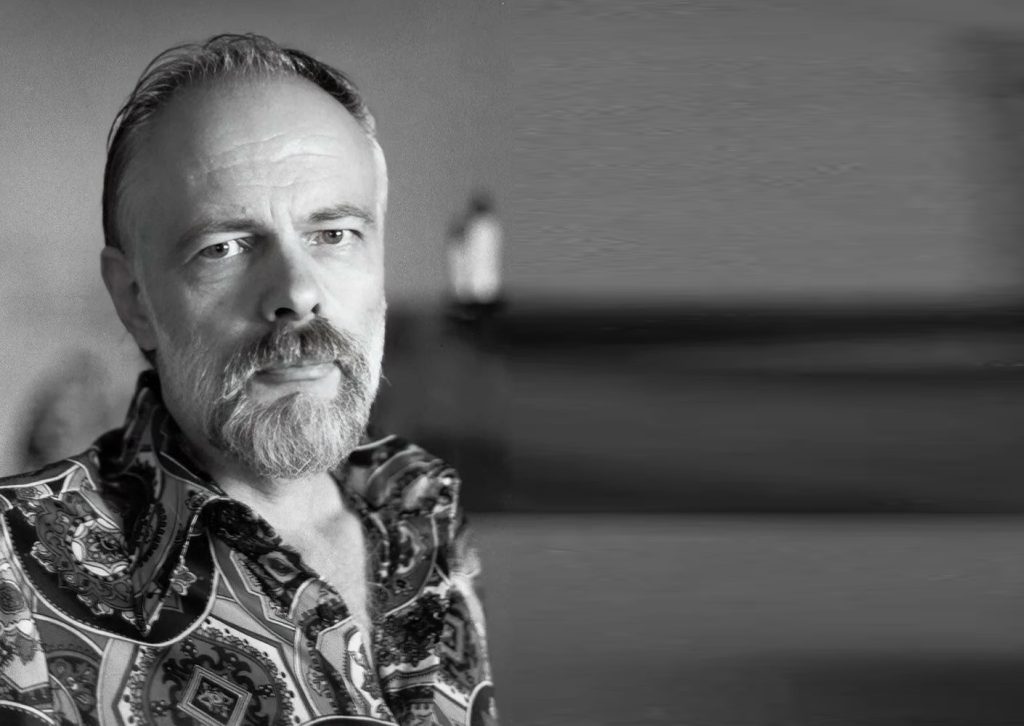Letteratura: l’autore che ispirò il fantascientifico Blade Runner entra nella storica collana Mondadori
Nel 1999 usciva Matrix. Ridi e scherza sono passati ventisei anni da quando quel film, ideato e diretto da Andy e Larry Wachowski (ora Lilly e Lana), consegnava al grande pubblico una visione del mondo per molti ancora inedita: la realtà non è la realtà, era ciò che vi si raccontava, e prima di quanto si possa immaginare l’umanità sarà chiamata a combattere sul fronte di universi paralleli, contro una tecnologia fuori controllo. A chiunque, allora, Matrix suonava come una stupefacente profezia che, nel campo del cinema di fantascienza, apriva nuove spericolate strade; un po’ come avevano fatto la saga di Alien e, soprattutto, Blade Runner.
In verità era già roba vecchia: negli anni Ottanta si era infatti consolidato un movimento letterario dal nome indimenticabile, il cyberpunk, all’interno del quale autori come William Gibson e Bruce Sterling offrivano al lettore il racconto di un vivere in cui il confine fra la macchina e l’umano era più che labile e una vasta rete informatica iperconnessa vedeva viaggiare al suo interno, come attraverso un groviglio a più dimensioni, i protagonisti del «mondo nuovo».
Ma pure questo nucleo di scrittori, che dichiaratamente si rifaceva a James G. Ballard, William Burroughs e Kurt Vonnegut, aveva, in modo consapevole, un antecedente col quale ancora oggi – o meglio, soprattutto oggi – risulta difficile reggere il confronto: parliamo, naturalmente, di Philip K. Dick (Chicago, 1928 – Santa Ana, 1982), autore, oltre che del leggendario Gli androidi sognano pecore elettriche? (da cui Ridley Scott trasse il sopraccitato Blade Runner, 1982), di un’opera vastissima, che consta di decine e decine di libri e alla quale, recentemente, Mondadori ha dedicato nientemeno che un doppio volume nella collana dei classici Meridiani.
Introdotta da un saggio di Emanuele Trevi, curatore dell’edizione assieme a Paolo Parisi Presicce, e da una cronologia a firma di Emmanuel Carrère – lo scrittore francese ha dedicato a Dick la biografia Io sono vivo, voi siete morti, da qualche anno disponibile presso Adelphi – l’imponente raccolta Opere scelte è un segnale di profondo cambiamento nella percezione di un autore ritenuto fino all’altro ieri, sì, come geniale, ma pur sempre da confinare nel recinto dell’underground di successo. E non è certo un caso che ciò avvenga oggi, mentre l’AI prende sempre più piede e il nostro essere al mondo appare come schiacciato sull’online.
Sono undici, fra i molti, i romanzi qui selezionati, e vanno da quelli delle prime stagioni creative fino all’estremo dell’esperienza esistenziale e artistica di Dick. Segnato in fasce dalla perdita della gemella Jane (i suoi genitori fecero scrivere sulla lapide il suo nome accanto a quello della sorella e la data di nascita di entrambi), Dick crebbe soprattutto con la madre, con la quale ebbe un rapporto difficile e morboso. Manifestò presto il suo talento, dedicandosi fin da giovanissimo alla creazione di romanzi e racconti da completo autodidatta e trovando nella narrativa di fantascienza un terreno ideale per esprimere le sue ossessioni e i suoi sogni poetici. Resosi presto conto di poter campare attraverso una scrittura considerata di seconda categoria, fra un libro e l’altro, nel corso della sua burrascosa esistenza, Dick conobbe la dipendenza dalle droghe, ebbe infiniti problemi finanziari, manifestò disturbi psichici e praticò uno «sperpero incessante in divorzi californiani» (l’espressione è di Bolaño, nel descrivere il suo mandare a gambe all’aria matrimoni uno dietro l’altro).
Fra i capolavori riuniti nei tomi in questione, troviamo, ovviamente, Gli androidi sognano pecore elettriche?, così come libri chiave quali L’uomo nell’alto castello (in italiano solitamente noto col titolo La svastica sul sole) e Ubik. Le traduzioni sono di Paolo Parisi Presicce, Gianni Pannofino, Marinella Magrì e Gabriele Frasca.