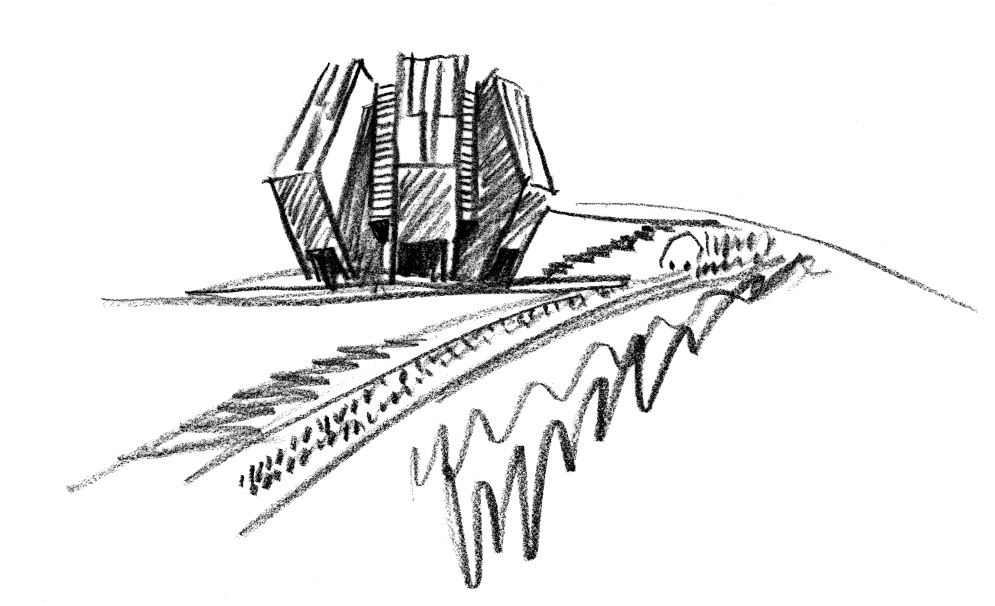Il grande architetto ticinese parla delle sue origini contadine, del camion Migros che arrivava nel villaggio di Genestrerio quando era piccolo e dei valori che l’hanno accompagnato nella sua esperienza di uomo e di protagonista della vita artistica internazionale
«Sono nato nel 1943 in una famiglia matriarcale a Genestrerio, all’estremo sud della Svizzera. Sono cresciuto attraverso il mondo delle donne. E ho avuto la fortuna di sentire da loro il racconto della guerra, che ho solo sfiorato. Ma soprattutto il racconto vissuto della vita contadina della mia famiglia, con gli animali, la raccolta della frutta e della verdura. Un mondo rurale che mi ha modellato profondamente. Anche oggi, dopo ottant’anni di vita, non lo dimentico. Sono elementi primordiali che ti restano addosso, ti segnano».
A parlare, nel suo studio di Mendrisio, un immenso open space popolato di modellini di edifici in cartone, scrivanie colme di rotoli, foto, lampade da tavolo e disegni, è Mario Botta, un architetto che non necessita di presentazioni. Ci sediamo a uno dei tanti tavoloni, più libero degli altri, perché qui ogni piano di lavoro è il suo ufficio e la conversazione parte da lontano, dall’ambiente contadino che l’ha generato.
Si porta addosso quel mondo l’architetto Botta, che poi nella vita ha costruito ville, campus universitari, fabbriche, musei, chiese, biblioteche e si è immerso coi suoi progetti nel cuore delle città del mondo.
«I sentimenti più forti ti restano nell’infanzia» confessa. «Credo che a dieci anni sei già un uomo. Le esperienze che vivi allora durano tutta la vita. Ricordo quegli anni del vivere contadino nella piazza. La mietitura del grano, l’arrivo della trebbiatrice in paese, come se fosse una giostra, una grande festa per tre giorni: per il grano che arrivava come una benedizione. Da bambini non potevamo aiutare più di tanto, ma potevamo viverne gli aspetti positivi e ludici. La fiera, la festa, gli elementi che hanno segnato la mia infanzia resistono dentro di me. Così come i lutti, la morte di mia nonna, che si è spenta dopo i novant’anni in una casa contadina, con tutti attorno a recitare il rosario e lei stessa che l’ha sgranato fino all’ultimo. Una fine auspicabile. Non sono nostalgico, ma questa cultura contadina è un privilegio che la mia generazione ha vissuto; il fatto – intendo – di aver sentito il profumo della terra nelle diverse stagioni».
Da questo viene un rapporto forte con la terra e i suoi frutti?
Certo. Noi si mangiava prima di tutto i frutti della terra, poi mia nonna con le sue figlie, le mie zie, vendeva i propri prodotti al fruttivendolo, il quale a sua volta li vendeva alla Migros.
A proposito, quali sono i suoi primi ricordi di Migros?
Come molti, ricordo noi bambini che giravamo attorno ai furgoncini della Migros: erano un’attrazione. I papà e le mamme lo vedevano come un negozio forse un po’ più ricco di come lo immaginavano a quei tempi, ma per noi il camion della Migros era una festa quando arrivava in paese.
Che rapporto ha, in generale, con Migros?
Duttweiler era un visionario e io ancora oggi lego questa personalità agli esordi della grande distribuzione che si spingeva sin nei più minuti villaggi della Svizzera. La distribuzione alimentare è un capitolo di storia del nostro Paese che ho potuto vivere direttamente, e di cui ho seguito poi l’enorme sviluppo. In fondo, la Migros dei primordi, quella della mia gioventù, ha scandito quegli anni di consumismo dal volto umano. Molte cose le ho scoperte dopo, ma fin da subito mi era chiaro che aveva un fondamento sociale molto ampio e che distribuire le merci per Migros era anche un’opportunità per aiutare lo sviluppo, allentare le tensioni, sostenere le proposte e i valori culturali. Associo la Migros indirettamente anche al sostegno al cinema e alla carta stampata.
Una curiosità di parte: leggeva già «Azione»?
Anche oggi per me «Azione» è una lettura fissa. Ma ricordo ancora il direttore Vinicio Salati e soprattutto Luciana Caglio (già redattori responsabili di «Azione»), che saluto e abbraccio perché è stata una compagna di viaggio di molti itinerari delle mostre in Ticino e non solo.
In tempi molto più recenti lei con Migros ha avuto a che fare anche per il Fiore di Pietra sul Monte Generoso.
Fu l’allora sindaco di Mendrisio Carlo Croci a dirmi che c’era l’opportunità di fare qualcosa di speciale in vetta al Generoso. E io sono scattato immediatamente perché il Generoso per noi del Mendrisiotto è la «nostra» montagna. Mi sentivo impegnato in un territorio amico. Mi venivano in mente i racconti che ascoltavo da adolescente, a Genestrerio, e che parlavano dei bombardamenti su Milano che si vedevano proprio dalla cima del Generoso. Mi dicevano che le luci sembravano quelle dei fuochi d’artificio. Come avrei potuto rifiutare un progetto da realizzare proprio lassù?
Lei ha interiorizzato i cicli stagionali della civiltà contadina da cui proviene, poi è passato all’architettura.
Quando ho finito le scuole dell’obbligo ho avuto la fortuna di fare l’apprendista da Tita Carloni, che all’epoca era già uno dei maggiori architetti. Ho incrociato allora un mondo che sarebbe maturato dopo, un mondo di ricchezza culturale, di riviste, di pubblicazioni, di apprezzamenti per l’architettura che sono indispensabili per far crescere la disciplina. Abbiamo un secolo intero dedicato alla cultura architettonica, ma la forza dell’architettura svizzera non è un miracolo spuntato dal nulla. Per i fondatori della cultura architettonica svizzera, Borromini, che ha lavorato nella Roma del Seicento, non è poi così lontano nel tempo.
Un amore a prima vista, per lei, quello per l’architettura?
Settant’anni fa ho cominciato a interessarmi a questa passione, a questa attrazione della forma architettonica, della missione architettonica del fare che mi ha portato a declinare i diversi momenti della vita attraverso il mio mestiere. Sono un animale architettonico, non ho la capacità di fare astrazione dalle altre discipline. Il mio mondo professionale, il mio lavoro, è la mia vita.
L’architettura in Svizzera gode di buona salute?
Ci sono state diverse stagioni. Vorrei parlare di quella del privilegio della modernità. Una conquista sulla scia del Bauhaus e di quegli architetti che hanno segnato il XX secolo, come Le Corbusier che era un mostro di consapevolezza disciplinare.
Ha fatto uno stage anche da lui, in gioventù, vero?
Sì, nel suo studio a Parigi, ma non posso dire di averlo davvero conosciuto come persona. Conosco invece molto bene la sua opera.
Lei è un maestro dell’architettura moderna, ma le piacciono i tempi che stiamo vivendo?
Da un punto di vista esistenziale e culturale siamo nel mondo del consumo. Un mondo su cui mantengo parecchie riserve ma di cui valuto anche gli aspetti positivi. Abbiamo perso i cicli stagionali che ritmavano le nostre vite. Ma già ai tempi dell’università vivevo in un mondo molto lontano da quello delle mie origini, quello della terzializzazione del vivere. Una stagione, tra l’altro, molto felice per il Canton Ticino. Certo, da architetto osservo che le nuove cattedrali della società di massa sono gli spazi della grande distribuzione: di merci, di traffico, del benessere, ma anche della cultura. L’architettura si adatta ai nuovi ritmi, se la gente è libera il sabato si creano centri di aggregazione a tutti i livelli alla fine della settimana. L’architettura si è adattata. La gente oggi ha una mobilità che prima non aveva e si sposta dove trova quello che cerca.
Cosa pensa dell’urbanizzazione?
Bisogna distinguere l’urbanizzazione, che ha portato anche in Svizzera alla sempre maggiore costruzione di vie di transito, dalle città. Le autostrade che noi abbiamo visto formarsi, ci permettono non solo di modificare il territorio, ma anche il nostro modo di essere. E le relazioni possibili fra le città, comprese quelle svizzere. Di fatto abbiamo sviluppato i centri di aggregazione sociale dentro le città. Ma le città, lo ricordo, sono la forma di convivenza sociale e culturale più bella, più ricca, più colta e flessibile del vivere collettivo.
Non si rischia l’omologazione?
Il rischio esiste, ma dobbiamo ricordare che le città sono tutte in un qualche modo un luogo sacro. Nel tempo ognuna si è adeguata al proprio territorio, alla propria storia, alla propria orografia e ha sviluppato una propria funzionalità, risolta con la comodità dei ponti e dei passaggi, diversa da quella delle altre città. Il territorio alla fine è più forte di tutto il lavoro degli uomini. Con tutte le trasformazioni e gli errori che abbiamo commesso, se c’è speranza per l’architettura e per ogni architettura è nel disegno delle città e del territorio che le circonda. Ogni architettura mira a essere una parte della città, un qualcosa che si inserisce in un contesto più grande, che la supera.
Le piace l’aria che stiamo respirando?
Parto da Trump, che ha già legalizzato una condizione problematica: l’arroganza al potere, che oggi è accolta impunemente da tutti, mi sembra contraddire lo spirito di servizio che ci vuole per fare il bene comune. Il bene esige anche una riflessione di compassione, di attenzione, di servizio al di là del profitto economico. Per me che ho vissuto un tempo immune dalla guerra, vedere che siamo precipitati nella teoria del riarmo è un trauma. Mi sembra che così alle generazioni future venga negata la gioia del vivere.
Cosa pensa dell’Intelligenza artificiale in architettura?
Penso che, anche al di fuori dell’ambito architettonico, sia uno strumento formidabile che avrà una fortuna sfacciata. Avrà successo perché è condannata a soddisfare un mercato e a diventare un business. Ma ho una grande perplessità sul principio su cui si regge. So che lo sviluppo tecnologico e le conquiste che abbiamo fatto fino a oggi sono direttamente proporzionali alla velocità dei risultati che riescono a ottenere. Tutto è stato fatto per aiutare l’uomo in maniera sempre più rapida. Ma questa rapidità, è stato scientificamente dimostrato, è direttamente proporzionale all’oblio. L’IA ha nel suo DNA la moltiplicazione straordinaria dei dati e della rapidità. Se creiamo strumenti direttamente proporzionali al dimenticare creiamo una società di orfani. Orfani di se stessi. È come correre in continuazione contro il vuoto. È un discorso anche d’architettura. Se escludi il territorio della memoria, che oggi è un antidoto possibile alle follie della guerra, resti orfano di una parte della tua coscienza critica, che è data appunto dal «territorio della memoria».