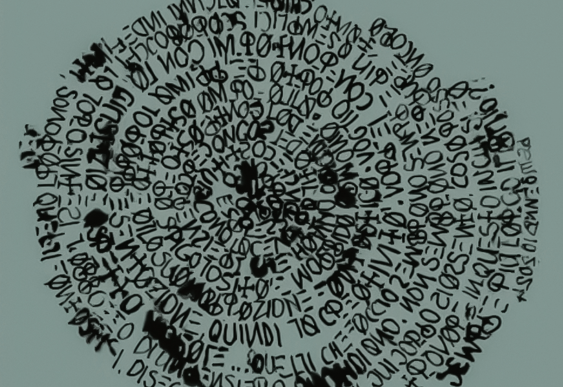Lo scambio tra storici e scrittori permette di imboccare percorsi inediti e stimolanti
Nel 1973 veniva dato alle stampe per la John Hopkins University uno dei testi fondamentali della teoria della storiografia moderna e postmoderna: Metahistory, The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, a firma dello storico statunitense Hayden White. In quest’opera, White introduceva un’analisi radicalmente innovativa della storia, interpretandola non (sol)tanto come una disciplina che tenta di descrivere oggettivamente il passato, ma anche e soprattutto in quanto forma di narrazione strutturata secondo specifiche convenzioni linguistico-letterarie e culturali.
Tramite l’analisi delle strutture narrative e retoriche adoperate da Hegel, Marx, Michelet e Nietzsche per dare forma alle loro interpretazioni del passato, White giungeva alla conclusione che i testi storici sono opere letterarie tanto quanto i documenti scientifici e che, nel redigerli, lo storico si comporterebbe al pari di un romanziere, usando il linguaggio per dare senso al caos delle esperienze umane.
Ciò significherebbe che, nel costruire la narrazione del passato a partire dalle fonti, gli storici non possono non confrontarsi con l’esigenza di organizzare i fatti esaminati in narrazioni coerenti, utilizzando tropi, generi letterari e modalità di argomentazione che tuttavia rifletterebbero le loro scelte retoriche e stilistiche da un lato, e una precisa visione del mondo dall’altro.
Lo storico, in sostanza, sceglierebbe non solo quali eventi includere, ma anche come raccontarli, ed è questo il punto essenziale, perché, come notato da Ludwig Wittgenstein, Jacques Derrida, Michel Foucault, il linguaggio non sarebbe capace di descrivere il mondo in modo neutrale e trasparente.
Se ogni narrazione storica è di conseguenza una costruzione influenzata dal linguaggio, così come dai presupposti culturali e dalle scelte dell’autore, ne risulterebbe che scrivere di storia significa anzitutto mediare tra fatti e significati, e sempre con l’ausilio del linguaggio e delle scelte retoriche.
Una storia non oggettiva, dunque, quanto invece interpretazione soggettiva della realtà, come tale ineluttabilmente legata alla temperie in cui di volta in volta vede la luce e suscettibile di continue riscritture.
Spingendo a riconsiderare nel profondo i limiti della conoscenza storica, si capisce perché Metahistory ha avuto un impatto così profondo sulla storiografia postmoderna: White aveva spostato l’accento su come il passato venga compreso e raccontato, piuttosto che semplicemente descritto.
A cinquant’anni di distanza, benché le critiche e i contrappunti alle teorie di White non abbiano mai cessato di infiammare il dibattito storiografico, il suo testo ha conservato il merito di aver aperto nuove prospettive sul rapporto tra linguaggio, narrazione e storia. Un intreccio che riaffermava le idee centrali del Linguistic Turn. Si potrebbe anzi affermare che Metahistory sia, in molti modi, un prodotto del Linguistic Turn.
Il Linguistic Turn – giova ricordarlo – è stato un movimento intellettuale attivo tra Europa e Stati Uniti tra prima e seconda metà del Novecento che ha fissato l’epicentro della riflessione dei pensatori appartenenti a questo importante fenomeno culturale nell’importanza del linguaggio e delle sue strutture nella costruzione della conoscenza. In particolare, in ambito storiografico il Linguistic Turn, al pari di White in Metahistory, ha individuato nell’incontro tra storia e letteratura una comprensione più ricca e problematica del passato secondo una prospettiva che apriva e apre tuttora un dialogo stimolante tra storia e letteratura nel quale si fa molto sottile il confine tra descrizione dei fatti e loro interpretazione immaginativa.
Anche in questo senso, il recente La Storia in gioco, Sedici documenti d’archivio tra ricostruzione storica e invenzione letteraria, a cura di Tommaso Soldini, scrittore, e Nelly Valsangiacomo, storica, presentato dalla Fondazione Pellegrini Canevascini e uscito per le Edizioni Casagrande, rappresenta davvero un ottimo esempio di dialogo, se anche implicito, con i presupposti teorici di Metahistory e del Linguistic Turn.
Se, secondo Hayden White, la storia dovrebbe essere vista non solo come una scienza, ma anche come un’arte narrativa, che utilizza tropi e strutture letterarie per dare senso al passato, in La Storia in gioco questo dialogo tra storia e letteratura assume una forma concreta, fruibile.
I sedici documenti presenti nel libro, selezionati da storici e storiche, vengono infatti reinterpretati da scrittori e scrittrici, che li utilizzano come punti di partenza per creare narrazioni immaginative stabilendo un legame biunivoco che non cerca di sostituire la verità storica con la finzione, ma di arricchirla, evidenziando come la letteratura possa aiutare a cogliere quegli aspetti emotivi e simbolici del passato che sfuggono all’analisi storica tradizionale.
Le fonti selezionate, così concepite, servono non soltanto ad aprire altrettanti squarci di luce sulla storia economica, sociale, culturale, di genere etc., del Canton Ticino tra XIX e XX secolo, ma divengono in parallelo fonti di ispirazione per nuove narrazioni che, attingendo dalla storia, si misurano con essa per scrivere delle storie, le proprie storie.
In ciò risiede proprio l’ambiziosa originalità di un testo che, nel ricercare un rapporto esclusivo e unico tra documento e lettore/lettrice, implicitamente tenta di concretizzare anche un altro concetto-chiave comune al Linguistic Turn e al libro di White, Metahistory.
Se, come esplicitato nell’introduzione a cura di Soldini e Valsangiacomo, ogni documento è portatore di un’esistenza che può essere ricostruita e reinterpretata, aprendo la strada a un’infinità di altre storie, allora la narrativa, lungi dall’essere un semplice esercizio creativo, diventa un mezzo per esplorare le connessioni tra memorie personali e collettive, tra il vissuto di chi ha prodotto i documenti e quello di chi li interpreta. Un approccio che per l’appunto rispecchia la tensione tra reale, fantastico e verosimile che caratterizza molte delle riflessioni nate dal Linguistic Turn.
È in conclusione un libro stimolante, La Storia in gioco, in grado di saldare l’interesse per la narrazione come strumento di conoscenza alla valorizzazione di voci e prospettive plurali, dimostrando al contempo che le intuizioni di Hayden White, spesso dimenticato, e del Linguistic Turn, al netto di criticità e limiti, possono essere cionondimeno tradotte in pratica, dando vita a un dialogo creativo e interdisciplinare tra storia, letteratura e memoria.